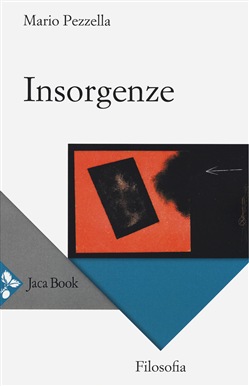di Marco Di Napoli
Mi propongo di fare da coro alla brillante e generosa analisi di Emilia Marra che molto gentilmente ha letto il mio lavoro sul desiderio, lo ha meditato, ed ha reagito con la scrittura attraverso una serie di folgorazioni che ne restituiscono il labirinto, i nodi problematici e le macchinazioni.
Lo strutturalismo insegna che non esiste struttura, per quanto chiusa, per quanto compiuta e sigillata, che non sia perseguitata da una crepa, da un elemento di squilibrio, da un perturbante capace di contro-effettuare la rigidità della codificazione in nome di una nuova assegnazione degli elementi fondamentali. Non si tratta solo di una ridistribuzione degli elementi secondari, accessori, ma proprio degli elementi portanti, quelli che si consideravano sacri, incontrovertibili ed immutabili. In tal senso la mia macchinazione, o come sottolinea Emilia Marra il tradimento che opero nei confronti di Marcuse, non era una semplice strategia di scrittura, un artificio retorico, non era un modo per mettere su carta un’improbabile e faustiana sperimentazione, ma era il tentativo di trovare nella scrittura una dimensione che pensavo non potesse più dischiudersi, una crepa nella scacchiera chiusa dell’inerzia culturale contemporanea. Avevo bisogno di tradire e di tradirmi, di sabotarmi e di contraddirmi, per poter vivere ancora, per poter respirare ancora. Avevo bisogno di incendiare le parole con dei vettori di deterritorializzazione incandescenti a cui ho provato a dare il nome di desiderio, per mettere il linguaggio sotto pressione in uno stato di calefazione tale che nello stesso momento in cui si surriscaldava, raggiungendo una temperatura impossibile, produceva una zona interstiziale fatta di una stratificazione isolante che mi permetteva ancora di esprimermi attraverso una sintassi umanamente comprensibile.
Si trattava di un procedimento insensato, labirintico, dispersivo, che dava vita ad una consistenza impercettibile e destabilizzante, oppure ad un’inconsistenza vaporosamente percettibile. Proprio la fiamma che avrebbe dovuto solarizzare totalmente il mio lavoro sul desiderio lo irradiava conservandolo paradossalmente in vita e facendone una sorta di ritornello, un balbettio aurorale, un improbabile posizionamento, un angolo di ricerca.
Seguendo lo scomodo sentiero di una dimensione notturna e sfuggente la mia scrittura diventava, stranamente, un preludio ad una filosofia dell’impossibile e questo era rafforzato dal fatto che la tematica del desiderio, almeno per come volevo trattarla, avrebbe dovuto incenerire tanto Marcuse quanto la mia stessa ricerca. Ma nell’imprevisto processo di calefazione che si produceva, senza che inizialmente me ne rendessi conto, si costituiva una zona isolata capace di conservare e contrastare, o quantomeno rallentare, quel processo di evaporazione che logorava la mia presa concettuale sfarinandola come se fosse stata una logora malta secolare.
Solo grazie a questa strana alchimia sono riuscito a mettere in tensione la mia personale macelleria e scagliarla contro l’auto-esaltazione del soggetto contemporaneo, con le sue funzioni prestazionali, contro i suoi codici linguistici iperattivi, contro i suoi regimi veritativi. Nello stesso momento si innestavano incontri assurdi con improbabili personaggi concettuali, un teatro barocco fatto di ripiegamenti con risonanze aliene, con linee di fuga labirintiche, con i movimenti aberranti della letteratura che mettevano in tensione i miei residui marxiani e freudiani con alcuni carsici fenomeni danzanti. Di fronte a tutto ciò non potevo non pensare che qualcosa di misterioso ed imperioso si fosse innescato proprio grazie alla potenza del desiderio che aveva già fatto di me, in quanto autore, un qualcosa di superfluo, un’ulteriore macchinazione.
Come ultima cosa vorrei aggiungere che quello contro cui lottavo era il fantasma rassicurante dell’inerzia, con il suo canto mortifero del “già detto”, soprattutto riguardo ad una tematica abusata come quella del desiderio. Così, nel sottosuolo nel quale mi sono ritrovato ad esistere, uno spiraglio ed un conforto era sicuramente rappresentato dal gesto di Mahler che era riuscito, anche se solo per un’ultima volta, a far gridare il sistema tonale attraverso il sistema tonale stesso, sconfinando nell’atonalità, ma senza convocare una dodecafonia di supporto. Mahler era riuscito a mettere in piedi una sua macelleria personale fatta di tagli, amputazioni ed innesti mostruosi che producevano continue esplosioni armoniche e melodiche. Allo stesso modo anche io ho provato a far risuonare qualcosa, sebbene con strumenti differenti, proprio nel momento in cui ho dovuto constatare che il mio deragliamento era irreversibile ed inevitabile. Così il mio tradimento strutturale e la mia misteriosa vocazione si smarrivano tra il compromesso codificato della scrittura e la calefazione messa in atto dalla dimensione del desiderio, in un labirinto che diventava tanto più terrificante quanto più si mostrava come abissale.