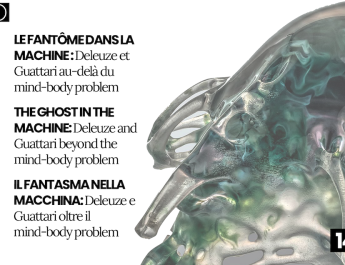Su Marco di Napoli, La dimensione del desiderio, L’ArgoLibri, Salerno 2023
di Emilia Marra
Credevo di leggere Marcuse e invece ero dentro un quadro di Francis Bacon. Per rendere giustizia al volume La dimensione del desiderio, di Marco di Napoli, mi sembra che occorra sostare sul piano epidermico e misurarne gli effetti a fior di pelle. Il libro, pubblicato per la prima volta nel 2020 da L’Argolibro, è stato riproposto alle stampe in una versione decisamente rimaneggiata nel 2023. L’elemento di continuità che si staglia su entrambe le copertine ha un rapporto di necessità con le pagine che seguono in grado di giustificare la manomissione della prima versione nella seconda: un labirinto su sfondo giallo. Che più di una lettura si tratti di una avventura lo si capisce fin dalle prime pagine, in cui l’autore annuncia a favore di pubblico che tradirà e non smetterà di tradire. Tradirà il primo esito delle sue ricerche, tradirà Marcuse e una certa eredità freudiana, tradirà, al modo del dissidente, l’oggetto stesso della sua ricerca. In effetti, il libro non può essere presentato nei termini di una ricerca sul desiderio, se non nel senso di una riflessione sul divenire per desiderio. Al contrario della maggior parte dei saggi filosofici, il cui intento programmatico viene spesso restituito dal titolo, e il cui sciorinamento coincide quindi già con la prima messa in forma del lavoro, Di Napoli rifiuta l’impostazione descrittivista per scegliere un approccio laterale, in cui, semmai, la prima parte del volume spiega perché il titolo è, e non potrebbe non essere, transitorio, già sorpassato, insufficiente nel suo intento documentaristico. Questo movimento, che con una parola densa di significato viene qui individuato come vocazione, è tensione vitale, trasformazione, dépense (per dirla con quello), possibilità di abitare poeticamente il mondo (per dirla con quell’altro). In assenza di vocazione, direzione non teleologica, élan vital irrinunciabile, il mondo non è altro che una macelleria egotica e surcodificata, sulla quale opera, dietro la maschera della razionalità strumentale, il dispotismo della mutilazione. Da questa finestra tutt’altro che edulcorata sul mondo della produzione capitalista si assiste alla messa in forma delle intuizioni di Marcuse, che denuncia l’annichilimento delle differenze individuali e la reificazione della dimensione relazionale. «L’uomo in frantumi e sparpagliato come su un campo di battaglia e di macello» (Nietzsche, Così parlò Zarathustra, trad. it. di M. Montinari, Adelphi, Milano 2001, p. 161). Sul tavolo del macellaio, il valore di scambio non è solo il minimo comune denominatore dell’umano, ma la misura del suo agire, in cui la stessa dimensione del desiderio non va semplicemente emendata bensì, scrive Di Napoli, resa funzionale al nuovo soggetto prestazionale. Perché la vocazione possa essere accolta in questo scenario, occorre che si faccia anch’essa merce, che il suo valore all’interno del sistema capitalistico sia chiaro e distinto. Insomma, del maiale non si butta niente, e il mondo in cui vive è un infinito piano di sfruttamento. Sale alla gola il grido alla pietà, la pietà per la carne macellata, per quella carne che, come ricorda Deleuze nel Francis Bacon. Logica della sensazione, non è archiviabile come semplice carcassa, ma ha conservato tutte le sofferenze della carne viva. Nel «fatto» della macellazione si dà l’identificazione con l’oggetto del proprio orrore e della propria compassione, la prima reazione al senso di isolamento, a quella sensazione di inconsistenza che ci rende così vicini al nulla. Si tratta di una dimensione estetica ed estatica insieme, di un senso di contemplazione che apre alla relazione non reificata come nuova dimensione del sensibile. Se, con Marcuse, la storia dell’uomo è la storia della sua repressione, con Di Napoli il presente dell’uomo contemporaneo è il presente della sua macellazione, un modo di esistenza che non permette di distinguerlo dalla bestia. Portatore di una indeterminata forza lavoro, quantificabile al kg, il soggetto può essere ottimizzato, e ciò che non è integrabile all’interno di questo sistema è scarto. In altre parole, nel momento in cui il proletario, la marxiana bestia da soma sofferente, diventa lavoratore autonomo incorporato nel sistema della produzione, egli «trascina le mutilazioni subite da millenni come eredità sociale» (T. W. Adorno, Dialettica negativa, trad. it. di P. Lauro, Einaudi, Torino 2004, p. 114), con una conseguente spettacolarizzazione del consumo, messa in scena della società del benessere, «estetizzazione del dominio» (p. 42). Nel modo estetico della macelleria, Di Napoli declina quindi, con cruda efficacia, l’inseparabilità di inclusione e repressione, integrazione e mutilazione, teorizzata da Freud e Marx e il cui ritmo è dato dal progresso tecnico. Il traditore compare allora come istanza di scardinamento, figura che scarta dalla tendenza adattativa alla quale il progresso addomestica, frizione «tra vita e forma, tra impulso vitale ed ordine, libertà caotica e controllo» (p. 55), denuncia della repressione addizionale mascherata da libertà nella società ultrarazionale. Il profitto fine a se stesso giustifica ai nostri occhi la mortificazione non necessaria dell’Eros? «Non più corpo del desiderio, ma corpo-strumento» (p. 64): c’è, specifica Di Napoli, una regressione delle pulsioni nel progresso, un loro appiattimento che rende impossibile non solo la rivoluzione, ma il sogno stesso della rivoluzione. La dimensione del desiderio è infatti dispersiva, oppositiva rispetto al flusso ininterrotto del miglioramento prestazionale, e va per questo incanalata, mercificata a sua volta, e il modo migliore affinché ciò accada è far sì che il soggetto desiderante voglia per sé la propria ottimizzazione. Si capisce allora perché l’efficienza come idea regolativa, kantiana solo nel suo essere illuminista, il cui rigurgito capitalista è l’apparenza ossimorica del concetto di tolleranza repressiva, è un altro nome della spettacolarizzazione, di una mortificazione non necessaria dell’altro, del non identico, un modo per disinnescare la domanda: che cosa può un corpo (desiderante)? Scrive Di Napoli, citando in coda Marcuse:
Sarà proprio l’esperienza trascendentale a passare in secondo piano di fronte all’assurdità del presente, il soggetto esistenziale si trova ad essere un punto interrogativo nello spazio, circondato e penetrato da inganni e delusioni dove la libertà viene esperita come elemento negativo, come peso da sopportare: «L’esperienza dell’assurdità del mondo, degli insuccessi e delle delusioni dell’uomo si presenta come esperienza della sua condizione ontologica»
(H. Marcuse, Esistenzialismo. Note sull’Essere e il nulla di Jean-Paul Sartre, in Id., Cultura e società, pp. 189-190)
Un corpo che desidera può, in primo luogo, stabilire un rapporto non cosale con l’altro, che smette di essere concorrente o rivale, termine di paragone all’interno di un movimento di comparazione basato sul principio di prestazione, per assurgere a occasione di coordinamento sociale e complicità (cfr. p. 80). Non si tratta di cambiare punto di vista sull’altro, ma di riconoscere l’esistenza di una sorta di inconscio prestazionale, responsabile del paradosso messo in luce da Marcuse: nel capitalismo avanzato del grande benessere, il soggetto continua a produrre infelicità, a sottrarre da sé la possibilità di desiderare. La linearità prestazionale non lascia spazio per il labirinto, per l’imprevisto, per la liberazione pulsionale creatrice, ma spaccia il desiderio per godimento amministrato, chiama liberazione sessuale l’appagamento codificato, e la tensione libidica si esprime solo nella ricerca di un altro da annientare, con cui competere. Di Napoli insiste sulla separazione tra desiderio e godimento: in quest’ultimo, l’altro è, al più, corpo esposto sul bancone del macellaio, e il godimento che si prova nella relazione con l’alterità reificata è un piacere di tipo pulsionale, che si dà nel tempo della mancanza e del consumo. Il corpo desiderante invece è un corpo vivo, che partecipa dell’altro, propensione che si dirige al mondo in modo costruttivo e creativo (cfr. p. 91), senza tradursi in bramosia di consumo, l’Eros liberato e rivoluzionario di Marcuse. Ritorna qui l’immagine proposta nella prefazione al volume, quella del desiderio come «una brace inestinguibile senza la quale l’essere umano sarebbe paralizzato, un essere astratto» (p. 97). Il riferimento alla brace permette di pensare l’intima connessione tra desiderio e divenire: l’Eros è forza che anima l’organismo, tensione verso l’impossibile, vocazione, resistenza e rivoluzione, costantemente imbrigliato e mutilato, trasformato in aggressività immotivata verso l’altro. Se l’altro è fuori da noi, egli è nemico; se è la parte di noi che ancora tenta una resistenza al principio di realtà, l’altro è nevrosi o malattia mentale. Il riferimento all’utopia permette di pensare il termine ad quem dell’Eros liberato come tensione verso l’impossibile, una nuova erotizzazione del mondo dal quale potrebbero sorgere relazioni e alleanze, l’apertura di quella che Di Napoli battezza una zona di indiscernibilità. Al suo interno, la sfera semantica del sacrificio scompare in favore di una visione altra della realtà, possibile e non per questo imposta, immaginifica nonostante l’unidimensionalità del presente. Questo il senso più profondo dell’intera operazione di Di Napoli: tracciare il piano del desiderio lungo la tensione impossibile tra Marcuse e Deleuze, immaginare l’incontro e la relazione tra codici, linguaggi, luoghi del pensiero che agiscono l’uno sull’altro come punti di tensione, e abitare il coro impossibile di una filosofia del e in divenire. Nel labirinto, Deleuze e Marcuse ascoltano il Mahler caro ad Adorno e incontrano il Mazzarò di Verga come figura emblematica della visione utilitaristica del mondo, si interrogano sul linguaggio incespicante di Mirra di Alfieri, assecondano e inseguono la riabilitazione della sensazione messa in moto da Keats. Nell’arte, i due filosofi trovano il tremendum, il luogo di una nuova fondazione, lo spazio dell’utopia.